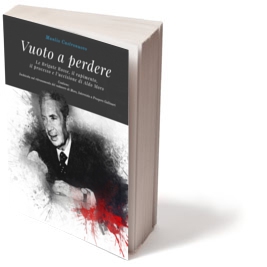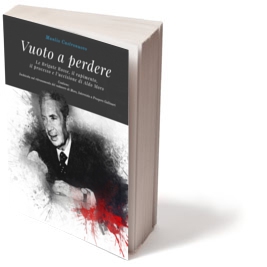|
|
Finalmente. Dopo il servizio dedicato ieri dal Corriere della Sera alle
«memorie riservate» di Giovanni Leone, del quale si celebra oggi il centenario
della nascita, non siamo più soli a collegare anche sul piano politico, e non
soltanto cronologico, l'interruzione del suo mandato al Quirinale con la
tragedia di Aldo Moro.
Del povero Leone i comunisti reclamarono le dimissioni, ottenendole grazie
all'aiuto dei democristiani, suoi amici di partito, non solo e non tanto per
soddisfare una feroce campagna scandalistica poi smentita nelle aule giudiziarie
con la condanna di chi lo aveva calunniato. Leone, come raccontammo su questo
giornale il 14 giugno scorso, nel trentesimo anniversario della sua
detronizzazione politica, dovette scontare la colpa di avere dissentito dalla
cosiddetta linea della fermezza durante il drammatico sequestro di Moro. Anzi,
di avere generosamente tentato di evitarne l'uccisione predisponendo la grazia
per Paola Besuschio, da lui scelta autonomamente fra i tredici detenuti indicati
dai brigatisti rossi per uno scambio collettivo con il presidente della Dc
sequestrato il 16 marzo dopo lo sterminio della scorta.
Una cinica ragione politica volle che il povero Leone fosse allontanato dal
Quirinale con ignominia per togliergli ogni credibilità, se mai fosse venuta a
lui o a qualche suo amico la voglia di partecipare al lacerante dibattito su ciò
che si poteva fare e non fu invece fatto per strappare Moro vivo ai suoi
aguzzini.
Non a caso a Leone quella voglia di parlare, riproponendo inquietanti
interrogativi sul sequestro del leader democristiano, venne solo venti anni
dopo, quando già i radicali, con encomiabile ravvedimento, avevano riconosciuto
l'errore di avere partecipato alla campagna contro di lui nel 1978 ed avevano
avviato la rivalutazione della sua figura. Ebbi il piacere e l'onore di
raccogliere quella volontà con un'intervista pubblicata sul Foglio del 20 marzo
1998 e raccolta il giorno prima nella sua villa all'Olgiata, le famose «Rughe»,
alla presenza della gentilissima signora Vittoria. Che può ora smentirmi o
correggermi, visto che mi accingo a rivelare di quell'incontro particolari
ancora inediti.
Ricordo ancora lo stupore di Leone quando gli attribuii una rinuncia a
graziare la Besuschio per via del rifiuto oppostogli dal presidente del
Consiglio in carica durante il sequestro Moro, che era Giulio Andreotti, e del
suo guardasigilli, che era Francesco Paolo Bonifacio.
«Conoscevo - mi spiegò - le condizioni politiche in cui si muoveva Andreotti,
per cui non mi passò neppure per la testa l'idea di consultarlo. La grazia era
di mia competenza. Quanto a Bonifacio, era stato mio allievo. Mi era devoto.
Tanto bastava per fidarmene. Le difficoltà incontrate furono di altro tipo,
inquietanti e incredibili».
Leone mi raccontò che, individuata la posizione della Besuschio come quella
più idonea ad una grazia sia perché non aveva materialmente ammazzato nessuno
sia perché era malata, per alcuni giorni non fu stranamente possibile conoscerne
il luogo di detenzione. Quando finalmente si riuscì a saperlo e a contattare
l'interessata, si scoprì che qualcuno l'aveva già raggiunta e convinta a
rifiutare la firma alla richiesta di grazia. Il ministro della Giustizia, leggi
alla mano, si mostrò sconsolato. Ma Leone lo rianimò rapidamente dicendo che,
pur in mancanza di un'apposita norma, destinata ad essere proposta e approvata
molti anni dopo, egli si sarebbe assunto ugualmente la responsabilità di
concedere la grazia. Vuol dire - confidò pressappoco a Bonifacio - che creeremo
noi il precedente che manca. E così la pratica non fu per niente abbandonata. Fu
semplicemente aggiornata, per la firma, a mezzogiorno del 9 maggio, che era il
giorno in cui risultava convocata la direzione nazionale della Dc. Dalla quale
Leone era stato esortato da qualche amico ad aspettarsi un segnale di
incoraggiamento o copertura politica. Gli era stata preannunciata, in
particolare, un'apertura di Amintore Fanfani, che oltre ad essere un leader
autorevole del partito di maggioranza ricopriva, come presidente del Senato, la
seconda carica dello Stato. Un suo assenso avrebbe potuto quindi risultare di
aiuto a fronteggiare anche il rischio di una crisi di governo, minacciata dai
comunisti con il ritiro della fiducia ad Andreotti se fosse risultata violata la
linea della fermezza.
Ma proprio la mattina di quel giorno, prima che la direzione della Dc si
riunisse, e che Leone potesse firmare una grazia capace quanto meno di riaprire
tra i terroristi una discussione sulla sorte dell'ostaggio, Moro venne
barbaramente ucciso. «A delitto consumato - mi dettò Leone perché fosse ben
pubblicato nell'intervista, come in effetti avvenne - mi convinsi che i
brigatisti fossero al corrente di quel che stava maturando e, non volendo la
liberazione di Moro, avessero affrettato quella mattina l'assassinio».
Chi poteva aver messo «al corrente» i brigatisti rossi di quel che andava
«maturando» al Quirinale e dintorni? Ecco la domanda che Leone, dimettendosi sei
mesi prima della scadenza del suo mandato, fu condannato a portarsi dentro. E
che, una volta posta dieci anni fa, fu fatta cadere ugualmente nel vuoto. Essa
meriterebbe finalmente una risposta, anche per rendere a Leone ciò che gli è
ancora dovuto, oltre all'onore che per fortuna gli fu restituito prima della
morte e ne permetterà il 12 novembre una solenne celebrazione al Senato alla
presenza del conterraneo Giorgio Napolitano.
Il Tempo 3 novembre 2008
|