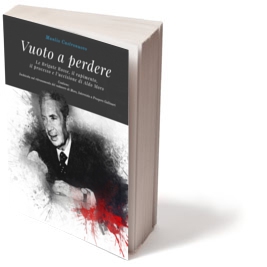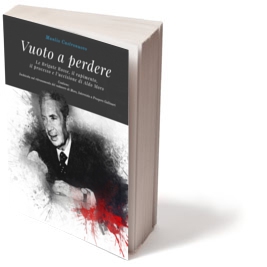|
|
L'intervista L'accusa agli ex militanti: troppo protagonismo
L'ultima Br del caso Moro «Gli altri scrivono libri io sono
l'unica in carcere»
Algranati: senza bilanci politici si alimentano le nuove leve
«Sono molto contenta che Marina Petrella sia riuscita a non essere estradata
e possa rimanere in Francia. Qui c'è solo il carcere. Anche lei, come me, è
un'altra persona rispetto a quella partita dall'Italia tanto tempo fa. L'ha
spiegato perfino il presidente della Repubblica francese. Marina almeno ha avuto
la possibilità di far conoscere le sue ragioni, cosa che io avrei fatto se in
Algeria fossi stata arrestata anziché essere condotta in una trappola. Invece
io...».
Invece Rita Algranati, ex brigatista rossa della «colonna romana», è
approdata in una prigione italiana senza alcuna procedura di estradizione nel
gennaio del 2004, venticinque anni dopo i fatti per i quali era stata
condannata. Dietro le sbarre s'è messa a a studiare, ha completato gli esami del
corso di laurea in Lingue e civiltà orientali. Voleva fare la tesi sui dialetti
arabi, ma il professore ha detto che sarebbe dovuta andare sul posto. «E io non
posso», ironizza. Deve scontare cinque ergastoli. Per il sequestro di Aldo Moro
è stata assolta, ma dopo che il verdetto definitivo alcuni ex compagni hanno
raccontato che c'era pure lei la mattina del 16 marzo 1978 in via Fani: era la
ragazza con il mazzo di fiori in mano, e diede il segnale che le auto del
presidente democristiano stavano arrivando.
Oggi è l'unica di quel gruppo brigatista chiusa in prigione.
Gli altri hanno finito di espiare la pena, sono in libertà condizionale o
escono almeno di giorno. L'ultimo latitante, il suo ex marito Alessio Casimirri,
è ancora rifugiato in Nicaragua. Anche lei è stata laggiù, poi in Algeria da
dove dopo 17 anni di permanenza è stata espulsa dalla sera alla mattina verso
l'Egitto; lì l'aspettava un gruppo di poliziotti dell'Antiterrorismo arrivati da
Roma, e nel giro di poche ore s'è ritrovata a Rebibbia. «Con un sotterfugio e un
atto illegale — racconta oggi la cinquantenne Rita Algranati, nella sala
colloqui del carcere, dove lavora come bibliotecaria — mi hanno portato qui
insieme al mio compagno, che sono stati costretti a liberare dopo un anno di
ingiusta detenzione perché la sua pena era prescritta. Io non ero più una
brigatista dal 1979, invece hanno dipinto quel prelevamento come un'importante
operazione antiterrorismo. Ma hanno preso un'altra persona, da 25 anni non ero
più la ragazza che aveva aderito alle Brigate rosse. Non rinnego nulla, ma dopo
due anni di militanza me ne andai per mia scelta. Che senso ha, oggi, tenermi
qui?». Quello di eseguire cinque sentenze di ergastolo. Lo Stato e i parenti
delle vittime non hanno diritto di vedere un condannato scontare la pena, prima
o dopo? «Se qualcuno oggi si sente risarcito dal fatto che io sono chiusa qui
dentro, va bene. Se c'è chi può essere ripagato dalla mia sofferenza, sappia che
quella sofferenza c'è. Mi hanno preso la vita. Ma non mi si venga a dire che c'è
una valenza rieducativa della pena, il fine di reinserimento nella società. Io
mi sono rieducata da sola, dal momento in cui sono uscita dalle Br perché non
comprendevo e non condividevo più la linea dell'organizzazione, quando mi
apparve che la lotta armata s'era trasformata da metodo in strategia, non più un
mezzo ma un fine. Ho scelto di andarmene con le mie gambe, senza portarmi dietro
le armi come altri. Sono andata all'estero e ho cercato di rendermi utile
altrove».
Lasciando che qui le Br continuassero a fare morti e feriti...
«Qui s'è andati avanti finché i pentiti non hanno provocato centinaia di
arresti. Loro sono stati premiati, ma non credo che abbiano scoperto i propri
errori dentro queste mura; mi sembra che abbia prevalso la convenienza... Il
problema è che chiuse in prigione le persone, nessuno ha voluto fare il bilancio
di quella stagione. Che certo è stata una stagione di violenza, ma violenza
politica, mentre ci si è fermati alle ricostruzioni giudiziarie». Colpa dello
Stato? «Lo Stato ci ha trattato come criminali comuni, negando valenza politica
a ciò che abbiamo fatto; anche per questo oggi io sono qui. Ma c'è pure una
responsabilità dei miei ex compagni che rilasciando interviste o scrivendo libri
hanno finito per avallare quell'impostazione. Si sono limitati a dire che la
guerra era finita e avevano perso; non una riflessione sui motivi per cui una
strategia fondata sulla violenza come valore in sé, che da un certo momento in
poi sembrava prevedere l'eliminazione fisica di tutti i nemici, abbia preso il
sopravvento».
Non prova nessun rimorso? Nessun pentimento?
Nessuna esigenza di chiedere perdono alle vittime, nemmeno oggi? «Io non ho la
cultura del pentimento. Penso che se uno fa un errore deve superarlo con la
pratica, provando a rimediare in altro modo. Ai familiari delle vittime potrei
dire un "mi dispiace" magari sincero, ma inutile. Sarebbe troppo poco. E
chiedere perdono, comunque a tutti e non solo a qualcuno, non avrebbe senso. Per
me l'autocritica, anche se è un termine obsoleto, è qualcosa di molto più
profondo di un mea culpa che suonerebbe strumentale, come fosse una merce di
scambio». C'è chi auspica almeno il silenzio di chi ha ucciso in nome di una
guerra dichiarata da voi, non certo dalle vittime. «Il fastidio per il
protagonismo di molti ex brigatisti, sinceramente, io lo condivido. Per il
motivo che ho detto prima: hanno parlato per giustificarsi e dichiararsi
sconfitti, non per analizzare gli errori. Anche per questo io non ho parlato e
non parlerò, almeno finché starò qui dentro. Di che cosa, poi? Dei singoli fatti
non servirebbe. Bisognerebbe fare, piuttosto, un bilancio politico che tra
l'altro servirebbe a togliere di mezzo quella sciagurata "continuità" tra le Br
di ieri e di oggi, che viene rivendicata mentre non dovrebbe esistere. Parlare
oggi di lotta armata è fuori da qualunque realtà».
Trent'anni fa, invece?
«Allora la violenza si respirava ogni giorno. Quella dello Stato, dei fascisti,
dei nostri cortei. Per molti la scintilla fu piazza Fontana; per me, che nel '69
ero solo una ragazzina, è stata l'omicidio di un compagno, Mario Salvi, ucciso
nel 1976 da un colpo di pistola alle spalle dopo una manifestazione dove forse
aveva tirato delle molotov. Anche se sembra una contraddizione, la lotta armata
è nata dall'odio per l'ingiustizia, ma pure per la violenza. Pensavamo che ci
fosse un'opzione rivoluzionaria, e quando mi sono resa conto che quell'idea
s'era trasformata in un'assolutizzazione della lotta armata, ho chiuso. Si
poteva fare, nessuno ti costringeva a restare».
Del suo arresto l'allora ministro dell'Interno Pisanu disse che era un
monito: chi abbraccia la violenza politica sappia che prima o poi lo Stato
arriva sempre.
«È esattamente il contrario. Mostrare il volto della repressione serve solo
a rafforzare chi vuole contrapporsi allo Stato. Non è la paura del carcere che
può dissuadere chi ancora pensa di sparare, ma la comprensione che s'è trattato
di un fenomeno politico fallito e improponibile. Di questo bisognerebbe
discutere, ma non mi pare interessi nessuno». Perché nel frattempo lei non dice
qualcosa sul caso Moro, per esempio? «Di quella vicenda penso si sappia tutto
quel che c'è da sapere, ma perché parlare di un episodio e non di altri? Per
quanto mi riguarda, io mi assumo la responsabilità di tutto ciò che hanno fatto
le Br a Roma tra il '77 e il '79, durante la mia militanza. Perché soffermarsi
su Moro e non sull'omicidio del giudice Tartaglione, o del colonnello Varisco?
Anche dal punto di vista umano, la morte è una tragedia per tutti, e tutte le
morti sono una tragedia. I dettagli non aggiungono nulla».
Giovanni Bianconi - Corriere della Sera, 14 ottobre 2008
|