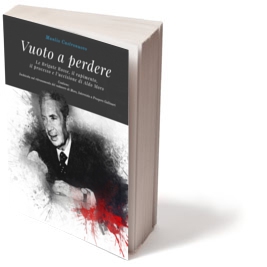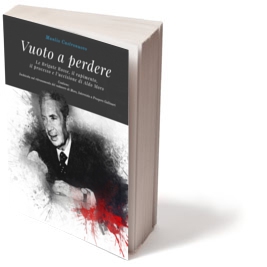|
|
Sono stato incerto se intervenire nel dibattito
sui modi e i motivi della «trattativa indispensabile» col gruppo di talebani
assassini che il governo afghano, sollecitato da quello italiano, ha condotto
per ottenere la liberazione del giornalista di Repubblica. Il lucido articolo di
Andrea Romano, con i cui giudizi concordo interamente, mi libera dalla colpa del
silenzio su questo evento. Ma mi ha colpito e stupito il confronto, da varie
parti ripetuto, fra questo episodio e il caso Moro.
Il governo, i partiti, tutta la stampa, giudicarono impossibile trattare con le
Br per liberare Moro. Qualcuno si è domandato «perché allora ci comportammo
così». E anche alcuni, che allora non ebbero dubbi sulla fermezza dello Stato,
si sono chiesti, certo in buona fede, se non avessimo sbagliato. La ferita
lasciata dall’assassinio di Moro, in tutti noi che ne fummo testimoni coinvolti,
non è ancora rimarginata.
E non consente il silenzio. Capisco che a distanza di quasi trent’anni, specie
dai più giovani, si siano dimenticate tante cose. Ad esempio, il fatto che per
impadronirsi dell’ostaggio Moro le Br avevano massacrato i cinque uomini della
scorta (in questi giorni, credo lo abbia ricordato soltanto Mario Cervi): o che
durante i cinquantacinque giorni della detenzione di Moro furono compiuti altri
venti attentati, e furono rivendicati altri due assassinii, fra cui quello di un
agente di custodia di San Vittore. Si chiamava Francesco Di Cataldo. Chi più lo
ricorda? Le forze dell’ordine avevano già versato molto sangue. Come si sarebbe
potuto, liberando dei terroristi assassini, mettere deliberatamente a rischio
altre vite di poliziotti o carabinieri?
Si è dimenticato quali fossero gli obiettivi strategici del rapimento di Moro,
come li definivano le stesse Br nei loro documenti: «Costruire il partito
comunista combattente... disarticolare la macchina dello Stato e nello stesso
tempo proiettarsi nel movimento di massa... Orientare, mobilitare ed organizzare
il Movimento di Resistenza Proletario Offensivo verso la guerra civile
antimperialista... Nelle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole, nelle carceri,
organizzare il potere proletario». I tanti omicidi garantivano che non si
trattava soltanto di uno «psicodramma» (noi diremmo una sceneggiata), come
Raymond Aron volle definire il ‘68 francese.
Si voleva colpire «il cuore dello Stato». E lo Stato, «il nostro Stato», come lo
definiva Carlo Casalegno, non poteva piegarsi al ricatto dei nemici della libera
Repubblica democratica che avevamo costruito. Casalegno, che nella Resistenza
era stato ispettore del Comando piemontese delle formazioni di Giustizia e
Libertà, aveva messo consapevolmente a rischio la sua vita, non per una assurda
idolatria dello Stato: ma per difendere lo Stato democratico che aveva
contribuito a creare.
Altro ancora si è dimenticato. Un documento, a firma di Aldo Moro prigioniero,
che le Br fecero giungere al pubblico italiano, conteneva parole (chissà come e
da chi concepite), che merita ricordare: «Da che cosa si può dedurre che lo
Stato va in rovina se, una volta tanto, un innocente sopravvive, e a compenso,
altra persona va, invece che in prigione, in esilio? Il discorso è tutto qui. In
questa posizione, che condanna a morte tutti i prigionieri delle Brigate Rosse
(ed è prevedibile ce ne siano) è arroccato il governo, è arroccata caparbiamente
la Dc, sono arroccati in genere i partiti». Involontariamente, questo passaggio
del documento, chiunque lo abbia pensato, spiegava perfettamente perché non si
poteva cedere. Eravamo stati avvertiti. Al primo sequestro, se avesse avuto
successo, ne sarebbero ovviamente seguiti altri; e forse a Moro si fece credere
che già ce ne fossero stati altri, o che fossero imminenti. Riconoscendo con una
trattativa il «partito armato», cedendo al suo primo ricatto, si sarebbero
provocati, inevitabilmente, altri sequestri e altri omicidi. Di uomini famosi e
delle loro scorte. O anche di semplici lavoratori. Si sarebbe mai potuto negare
a chicchessia lo scambio concesso per salvare Moro?
Chi, in quei giorni, incontrò Zaccagnini, o Cossiga, sa con quanta tremenda
sofferenza, dopo aver affrontato e superato quanti terribili dubbi, si dovette
rifiutare ogni scambio. Vicino a loro era Paolo VI, di schietta stirpe popolare
e antifascista, che aveva amato Aldo Moro, ma che, nella sua preghiera agli
«uomini delle Brigate Rosse», chiese la liberazione di Moro «semplicemente,
senza condizioni».
A distanza di anni, si può ben dire che quella fermezza, quel sacrificio, non
furono vani. L’assassinio di Moro e degli uomini della sua scorta, dopo i tanti
omicidi di agenti dell’ordine, di sindacalisti, di giornalisti, di magistrati,
fu il punto culminante di una svolta che segnò, prima di quanto noi allora
potessimo immaginare o sperare, l’inizio della fine delle Br. Il terrore rosso,
che il Pci di Berlinguer, con le sue forti radici antifasciste, aveva respinto
con orrore, fece il vuoto attorno a sé. Alla notizia della morte di Moro si
riempirono le piazze. Si svuotarono le fabbriche. Si manifestò con forza
inaspettata la solidarietà commossa di tutto un popolo. Quanti ricordi tornano
alla mente. Penso ai bravi, coraggiosi cronisti della Stampa (faccio un solo
nome per tutti, quello di Clemente Granata), che non avevano scorte, le cui
mogli ricevevano a casa telefonate minatorie, e che volevano firmare i pezzi che
dedicavano ogni giorno alle orrende imprese dei gruppi terroristici.
Ripenso alla bomba fatta esplodere alla mezzanotte accanto al muro esterno della
sala di spedizione del nostro giornale, che solo per un felice errore, frenata
da un’invisibile trave di cemento armato, non fece, come gli assassini
speravano, decine di morti fra i tipografi della Stampa.
E ritrovo più forte che mai nella memoria l’immagine di Carlo, il collega più
caro, che aveva scritto nel 1977 parole profetiche sulle Br: «Suscitano paura,
ma il loro terrorismo è senza sbocco». Carlo aveva chiara coscienza dei pericoli
cui si esponeva con le sue lucide analisi, per voler fare il proprio dovere. Per
allontanare, come allora scrivemmo, quella peste della violenza e del terrore
dalla nostra cara patria.
|