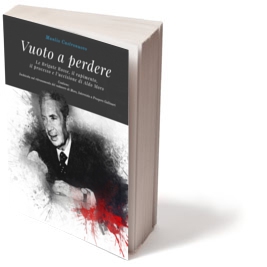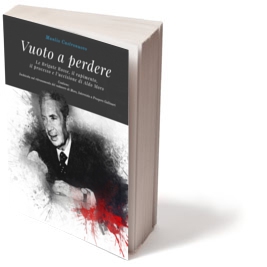|
|
Caro Direttore,
una mia riflessione sul rapimento di Aldo Moro
ha suscitato il commento di Sergio Romano, con le cui considerazioni (ieri sul
Corriere) vorrei interloquire. Premettendo che le mie parole non avevano nulla
di strumentale: non è per giustificare la trattativa per la liberazione di
Daniele Mastrogiacomo che mi sono chiesto se sia stato giusto arrivare al
supremo sacrificio della vita di Aldo Moro.
Ho vissuto la terribile stagione del terrorismo
a Torino che, per il suo valore simbolico di città Fiat e città operaia, fu
assunta dalle Br come uno degli epicentri della loro offensiva. Il rapimento di
Aldo Moro fu l’apice di quella lugubre stagione. E, superando iniziali reticenze
e incertezze, la reazione democratica non poté che essere dura e intransigente.
Ne fui partecipe e non mi sottraggo certo oggi alla responsabilità di aver
condiviso la linea della fermezza. Ma ciò non mi impedisce, a trent’anni di
distanza, di chiedermi se l’intransigenza di una giusta linea politica
richiedesse obbligatoriamente l’accettazione del sacrificio di una vita. Si
dice: «Se per Moro si fosse trattato, lo Stato avrebbe dato un segnale di resa
ai terroristi».
Allora, nel vivo di uno scontro durissimo,
condivisi questa impostazione. Oggi sono meno sicuro. Non sta scritto, infatti,
che una trattativa per salvare una vita umana debba necessariamente comportare
la resa alle ragioni di chi a quella vita attenta. Non credo affatto che se
avessimo ottenuto la liberazione di Moro, la nostra lotta al terrorismo sarebbe
diventata poi meno intransigente. Né credo che sarebbe aumentato il consenso
verso i terroristi. E, insieme alla vita di un uomo, avremmo forse anche salvato
la Repubblica da una lacerazione politica e istituzionale che negli anni
successivi avrebbe prodotto conseguenze dirompenti. In guerra — e quella con il
terrorismo era una vera guerra — lo scambio di prigionieri è procedura
contemplata e a cui si ricorre senza che nessuno dei contendenti rinunci alle
proprie ragioni e riduca la propria determinazione nel conflitto. D’altra parte
vorrà pure dir qualcosa che, dopo l’epilogo tragico della vicenda Moro, per
tutti i rapimenti successivi — dal giudice D’Urso all’assessore Cirillo — si sia
adottata una linea assai più flessibile, puntando alla liberazione con il
ricorso a trattative o a intermediazioni.
E in anni più recenti ogni volta che un
giornalista, un cooperante di Ong, un tecnico professionale sono stati rapiti in
Cecenia, in Somalia, in Iraq, in Afghanistan, in Nigeria, si è scelto sempre di
privilegiare l’obiettivo umanitario e di salvare una vita. E lo si è fatto senza
mutare le scelte politiche o gli impegni militari a cui l’Italia era tenuta. La
liberazione delle due Simone, cosicché come di Giuliana Sgrena, non hanno mutato
l’impegno dell’Italia in Iraq. Così come la liberazione di Mastrogiacomo non ha
ridotto le nostre responsabilità verso l’Afghanistan: duemila soldati italiani
erano lì prima del rapimento e duemila soldati italiani sono lì anche oggi, ad
assolvere con determinazione il mandato loro affidato da Onu e Nato. D’altra
parte, a conferma che una linea umanitaria non è così priva di senso, è
significativo che durante i rapimenti — quando la vittima è nelle mani dei suoi
carnefici—nessuno osa contestare la ricerca di contatti e l’avvio di trattative
con i rapitori. Il punto non è, dunque, se trattare o no, ma come salvare una
vita senza che questa scelta alteri o stravolga la coerenza di una linea
politica e gli impegni per la stabilità, la sicurezza e la pace che il nostro
Paese è chiamato ad assolvere.
Piero Fassino
|