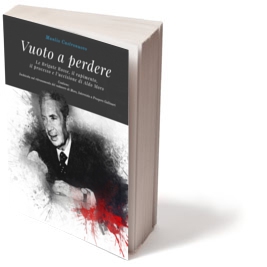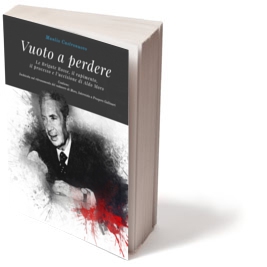|
|
Brigate rosse, Fenzi “si confessa” nella chiesa di San
Torpete
Genova - L’ex professore delle Br parla ai piedi di un altare, invitato da un
parroco. «In Chiesa si può anche bestemmiare, è un luogo libero», dice don Paolo
Farinella, parroco di San Torpete, una piccola chiesa nel cuore dei vicoli. E
Enrico Fenzi, 76 anni («Sette scontati in galera, più tre agli arresti
domiciliari») seduto accanto al prete parla liberamente. Di sé, di don Gallo che
a suo dire faceva “santini” dei terroristi irriducibili «e per tre volte la sua
Comunità mi ha impedito di parlare in pubblico», dice sollevando proteste. Del
clima degli anni vissuti insieme alla colonna genovese delle Brigate rosse.
Racconta verità inedite e senza prove: quella volta che, sostiene, un giudice
gli disse che Alì Agca lo accusava di avergli fornito la pistola per sparare a
papa Giovanni Paolo e i documenti falsi per fuggire. «Il lavoro dei servizi
segreti è questo - scandisce - creare false piste. Più d’una, in modo da poter
utilizzare al momento giusto quella più adatta. Se si fosse deciso di portare
avanti la pista dell’Est, il mio coinvolgimento sarebbe stato utile, una
costruzione perfettamente logica. Ma si cambiò strada».
Parla, soprattutto, della sua dissociazione che non è diventata “pentitismo”
per i giudici. «perché ho scelto di raccontare ciò che gli inquirenti sapevano
già e non ho invece confermato cose che avrebbero voluto che dicessi. Mi sono
sinceramente dissociato, pentito da un punto di vista morale. Ma sono stato
anche un ombrello, la pattumiera che doveva coprire lo sporco. Una piccola
pedina mossa chissà da dove e da chi». Eccola, la verità parziale di uno dei
protagonisti degli anni piombo che parla per la prima volta, apertamente, dopo
una dichiarazione pubblica estemporanea a Palazzo Tursi in occasione della
presentazione del libro che Andrea Casazza ha dedicato alla colonna genovese,
“Gli imprendibili”.
La figura che Fenzi vuole raccontare a chi l’ascolta, mentre parla col tono
dimesso di un vecchio studioso, è quella di un uomo che ha sbagliato e ammette
di averlo fatto. Un padre la cui ultima figlia è stata battezzata dal fratello
gesuita di Vittorio Bachelet, il giurista democristiano assassinato da un
commando brigatista a Roma nel 1980. Uno che si sente responsabile nei confronti
delle vittime e dei loro familiari, ma non vuole che lo Stato si dica innocente:
«Ricostruire la storia di quegli anni è quasi impossibile, la verità non
esiste», dice. Di più.
«In Germania si poteva dire che i terroristi della Raf erano criminali e che
la Repubblica federale tedesca era pura come una colomba. Distinguere il bene e
il male. Io però non sono sicuro che in Italia lo Stato sia altrettanto
innocente». Sono invece vittime innocenti le persone ferite o uccise dalle
Brigate Rosse o da altri gruppi terroristici. «E per questo lo Stato ha usato i
feriti e i familiari degli ammazzati - continua - investendoli di un ruolo di
supplenza morale, col pessimo risultato che la giustizia ha assunto i colori di
una vendetta». Parole che qualcuno ascolterà con sgomento, riportate da un
cronista.
Enrico Fenzi, per le cronache giudiziarie, nella sua vita brigatista ha preso
parte a una sola azione di fuoco: la gambizzazione del dirigente Ansaldo Carlo
Castellano nel 1977 («Mi coinvolsero per mettermi in una condizione di non
ritorno», dice). E Castellano, che porta ancora nel fisico i segni di quell’agguato,
oggi reagisce all’idea di un ex brigatista che parla in chiesa di uno Stato che
“usa” le vittime del terrorismo. «È un’affermazione ingenerosa e assurda - dice
a botta calda - meglio per ora non aggiungere di più perché le ferite sono
aperte, il terrorismo è stato una cosa grave. Ma certo mi lascia perplesso che
Fenzi sia stato accolto in una chiesa per dire certe cose».
Dal pubblico, un suo ex collega all’Università, Elio Gioanola, chiede a Fenzi
come può parlare tranquillamente di ammazzare la gente «uno come te, un uomo
pacifico». Uno studioso che ha appena pubblicato un’edizione del “De Vulgari
eloquentia di Dante” ed è stato chiamato a parlare di Petrarca alla Sorbona.
«Viviamo in un mondo dove normalmente si uccide», risponde lui, con lo sguardo
basso e lo stesso atteggiamento mite, ai piedi dell’altare.
Bruno Viani (Il secolo XIX, 30 gennaio 2014)
|