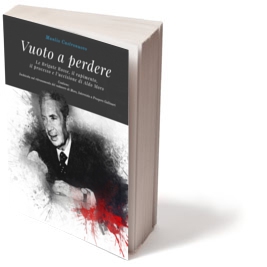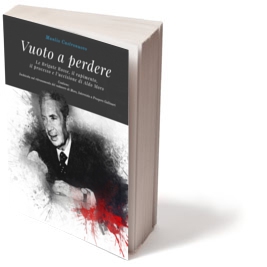|
|
Il prete che sussurrava ai boss
L'uomo che sussurrava ai mafiosi ha settant'anni, gli
occhi piccoli, i capelli brizzolati, la pelle liscia, la faccia rotonda, lo
sguardo fisso, un sorriso inciso sul volto da due sottili rughe che gli
incorniciano le labbra e un ricordo nitido di quello che successe la mattina del
30 maggio 1993 di fronte al presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro:
"Pensi a un nome lei, caro monsignore".
L'uomo che sussurrava ai mafiosi ha un passato nelle
parrocchie di Siena, una lunga esperienza nelle carceri toscane, un tosto
addestramento alle scuole diplomatiche e una storia da raccontare su quello che
Papa Montini gli mostrò a Castel Gandolfo tre giorni prima che Aldo Moro venisse
ucciso dalle Brigate Rosse: "Guardi cosa c'è lì sul tavolo, caro monsignore".
L'uomo che sussurrava ai mafiosi, e che a volte
sussurrava anche ai brigatisti, ai terroristi, ai camorristi, agli assassini e
ai semplici criminali, ha una biografia che si intreccia con i fatti di alcuni
fra i più indecifrabili misteri d'Italia e contiene diversi elementi che danno
un senso a molte delle scene recitate nella famosa commedia intitolata "Le
trattative stato-mafia". L'uomo che sussurrava ai mafiosi si chiama Fabio
Fabbri, è stato per vent'anni il braccio destro del più famoso cappellano
d'Italia (don Curioni), ha lavorato a fianco di due Papi (Montini e Wojtyla), di
tre presidenti della Repubblica (Leone, Pertini, Scalfaro), di due ministri
della Giustizia (Martelli e Conso), di due ministri dell'Interno (Scotti e
Mancino), e tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Novanta è
diventato il simbolo di quella naturale zona grigia maturata nei secoli tra il
mondo delle istituzioni e il mondo della criminalità organizzata.
Insomma, sì: parliamo dell'intrigante e oscuro universo
dei cappellani delle carceri, e di tutti quei preti che nottegiorno vivono le
prigioni provando a trattare, ad ascoltare, a mediare, a incoraggiare, a
rincuorare, a stimolare, ad assistere, e magari anche a convertire, e non
necessariamente dal punto di vista religioso, tutte quelle persone che da dentro
gli istituti penitenziari cercano di rimettersi in sintonia con il mondo reale,
e tentano di far arrivare, per quanto possibile, la propria voce anche al di là
delle sbarre. L'uomo che sussurrava ai mafiosi lo incontriamo a Roma, nelle
stesse ore in cui magistrati, giornalisti, editorialisti, avvocati, direttori e
fondatori di giornali si massacrano sui quotidiani attorno alle appendici varie
di quel mostro giuridico chiamato "trattativa stato-mafia". Don Fabbri ha letto
tutto quello che c'era da leggere sulle accuse a Nicola Mancino, sulle
insinuazioni lanciate contro Giorgio Napolitano, sulle critiche a Oscar Luigi
Scalfaro, sulle teorie di Antonino Ingroia; ma, come gli capita ogni volta che i
suoi occhi si ritrovano a contatto con tutte le storie legate alla morte di
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e alla fine della stagione delle stragi, con
il pensiero, don Fabbri, non riesce a non andare ancora a quella mattina del
1993: quando all'improvviso Oscar Luigi Scalfaro convocò al Colle la coppia dei
cappellani più famosa d'Italia: don Fabbri e don Curioni. I giorni erano
piuttosto caldi, diciamo, e al centro delle attenzioni vi era il dossier
relativo all'applicazione del carcere duro per i mafiosi (la famosa estensione
del 41 bis, modificato e irrigidito dal governo l'8 giugno del 1992, sedici
giorni dopo la strage di Capaci).
Tre mesi prima della convocazione di Curioni e Fabbri,
all'inizio di febbraio, in alcune carceri italiane si era infatti cominciato a
diffondere un certo clima di rivolta contro il 41 bis: a Napoli, per esempio, al
reparto Venezia, settore riservato ai detenuti più pericolosi del carcere di
Poggioreale, alcuni camorristi, per protestare, avevano ucciso un sovrintendente
della polizia penitenziara; e in quelle stesse ore, mentre il governo come
reazione all'omicidio decideva di estendere l'applicazione del 41 bis a tutto
l'intero penitenziario, i familiari di alcuni boss mafiosi stavano preparando
una lettera indirizzata al presidente della Repubblica (arrivò il 17 febbraio)
in cui si chiedeva a Scalfaro, in quanto "rappresentante e garante delle più
elementari forme di civiltà", di prendere posizione contro il 41 bis e di
togliere di mezzo "gli squadristi al servizio del dittatore Nicolò Amato".
Nicolò Amato, ai tempi, era il numero uno del Dap (il dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria, "organo di coordinamento dell'ordine e della
sicurezza delle carceri", che all'epoca aveva persino la possibilità di firmare
autonomamente i decreti delegati sul 41 bis), e la ragione per cui Scalfaro
convocò Curioni e Fabbri era legata proprio al nome di questo apparentemente
anonimo burocrate statale.
"Scalfaro - racconta oggi Fabbri, nipote dell'ex vescovo
ausiliare di Firenze Giovanni Bianchi, ex viceparroco della chiesa Santo Spirito
di Siena, ex cappellano del carcere della sua città, e con un passato nella
scuola dei diplomatici della Santa Sede - ci chiamò, ci fece salire nella sua
stanza privata, ci fece accomodare, ci guardò negli occhi, ci rivelò tutta la
sua preoccupazione rispetto alla situazione delle carceri e poi, alla fine della
nostra discussione, ci disse chiaramente che era arrivato il momento di
sostituire il direttore generale del Dap, e di pensare noi stessi a un possibile
sostituto per quel ruolo importante. Scalfaro ci confidò che con Amato non aveva
un buon rapporto, ci raccontò che il numero uno del Dap si comportava in modo
altezzoso e ci fece capire che a suo avviso non poteva più essere egli la
persona giusta a cui affidare in quel momento il coordinamento delle carceri
italiane. Noi fummo presi alla sprovvista, e, mentre pensavamo a cosa
rispondere, Scalfaro ci disse che non gli occorreva subito un nome, ma che una
risposta sarebbe stata apprezzata il giorno dopo quando l'allora ministro della
Giustizia Giovanni Conso, così ci disse Scalfaro, ci avrebbe ricevuto per
parlare proprio della questione". E così andò. "Il giorno dopo - continua don
Fabbri - arrivammo al secondo piano di Via Arenula, entrammo nell'ufficio di
Conso e mentre il ministro ci chiese se avevamo qualche nome da suggerire per
rimpiazzare Amato a me venne un lampo: guardai Curioni e gli sussurrai a voce
forse più alta del dovuto il nome di Adalberto Capriotti. Capriotti all'epoca
era un magistrato di Trento, un buon cattolico, uno serio ma non rigido, e un
personaggio attento e vicino al mondo dei cappellani. Curioni stava per
rispondermi con un cenno di intesa; ma, poco prima che Curioni potesse dirmi
qualcosa, Conso si alzò in piedi, si avvicinò a una vecchia cassettiera di
legno, prese un librone molto grande, cominciò a sfogliarlo, e iniziò a leggere
le caratteristiche di Capriotti, la sua età, la sua storia e la sua posizione, e
dopo pochi minuti disse di sì: ‘D'accordo, per me può andare'. E in effetti così
andò nuovamente: quattro giorni dopo, il 4 giugno, Amato fu cacciato dal Dap e
Scalfaro e Conso nominarono come capo del dipartimento proprio lui: il nostro
Capriotti".
La scelta improvvisa di Capriotti e la destituzione dal
vertice del Dap di Nicolò Amato coincise con una svolta radicale nell'approccio
scelto dallo stato e dalle istituzioni con il mondo delle carceri e
indirettamente con il mondo della criminalità organizzata. Capriotti, che, come
detto da Fabbri, era "uno assai attento e vicino al mondo dei cappellani",
condivideva le preoccupazioni espresse nei mesi precedenti sulle condizioni
delle carceri dai 235 cappellani rappresentati nel consiglio pastorale italiano
proprio da don Fabbri e don Curioni. E proprio come i due cappellani, Capriotti
era "indignato" per l'applicazione così severa e inumana del 41 bis, e durante
la sua esperienza alla guida del Dap non fece mai mistero delle sue opinioni sul
tema del carcere duro: al punto che, senza nessun sotterfugio ma in modo
trasparente, nei mesi successivi iniziò a coordinare una campagna martellante
rivolta al governo per rivedere radicalmente le norme sul 41 bis. Una campagna
che ebbe il suo primo atto pubblico in una nota scritta - proprio dal Dap - il
26 giugno 1993, in cui Capriotti, invocando "un segnale di distensione" e
richiedendo una "diminuzione del 10 per cento dei decreti 41 bis, una riconferma
dei decreti per i boss prossimi alla scadenza annuale e un dimezzamento della
durata del 41 bis da un anno a sei mesi", delineò, anche qui in modo
trasparente, quella che era diventata una nuova e più complessa strategia
giudiziaria. Una strategia che nei mesi si manifestò attraverso un'altra serie
di episodi di cui Capriotti fu sempre protagonista. E proprio su questa scia, il
29 luglio arriva una seconda nota del Dap, che sulla falsariga di quella
precedente indica - questa volta in modo più esplicito - come "la delicata
situazione generale imponga da una parte di soddisfare le esigenze di sicurezza
e di contrasto alla criminalità organizzata e dall'altra di non inasprire
inutilmente il clima all'interno degli istituti di pena".
Il 7 agosto, poi, è il segretario del Comitato esecutivo
per i servizi di informazione e sicurezza, Giuseppe Tavormina, a inviare a
Nicola Mancino (allora ministro dell'Interno) un documento in cui mette in
chiaro come la strategia del carcere duro avrebbe contribuito ad aggravare la
tensione nel paese, e non a stemperarla: "Il nesso tra gli attentati mafiosi e
il 41 bis - scrive nell'appunto Tavormina, riferendosi agli attentati del 27 e
del 28 luglio alla chiesa di San Giorgio al Velabro, alla basilica di San
Giovanni, a Roma, e al Padiglione di arte contemporanea di n via Palestro a
Milano - è una possibile matrice dell'ondata stragista". Passano i giorni,
passano i mesi, ci si avvicina alla fine dell'anno, il Dap e i cappellani
continuano, alla luce del sole, la loro battaglia per la revisione del carcere
duro, e nel giro di tre giorni, a cavallo tra il 29 ottobre e il primo novembre,
succede quello che fino a pochi mesi prima nessuno avrebbe mai immaginato
potesse succedere: il Dap invia una richiesta scritta al ministro Giovanni Conso
(e per conoscenza anche al procuratore capo di Palermo, Gian Carlo Caselli, e al
presidente dell'Antimafia, Luciano Violante) per chiedere "il rinnovo del regime
speciale solo nei confronti di quei soggetti che nell'ambito della criminalità
organizzata rivestono posizioni di particolare rilievo e lasciare decadere il
provvedimento nei confronti di quei detenuti di minore spessore criminale".
Questa volta la richiesta va a buon fine, finalmente i
cappellani possono esultare e tre giorni dopo quella richiesta succede che il
ministro Conso (chissà se davvero in "perfetta solitudine" come ha raccontato
qualche mese fa ai magistrati) lascia clamorosamente decadere i primi 140
decreti sul 41 bis (i successivi 567 decadranno più avanti, nel gennaio 1994).
Eccola qui, secondo il capo dei cappellani, la vera storia sul 41 bis. Altro che
estorsione. Altro che ricatto. Altro che cedimento. Altro che inginocchiamento
dello stato. "Vedete - continua Don Fabbri - io non credo che si possa parlare
di chissà quale trattativa, e anzi credo che la storia sul 41 bis vada letta
sotto una lente di ingrandimento diversa rispetto a quella che è stata impugnata
da alcuni pubblici ministeri. Le cose andarono in modo semplice: noi cappellani
avevamo avvertito le istituzioni che un irrigidimento delle misure di sicurezza
non avrebbe portato alcun tipo di beneficio, e che anzi avrebbe contribuito a
peggiorare e a rendere ancora più disumano il già disumano regime carcerario.
Scalfaro, evidentemente, si mostrò sensibile alle nostre osservazioni e sfruttò
la nostra esperienza per portare avanti non un gesto distensivo nei confronti
della mafia ma semplicemente un atto di buon senso". Scalfaro, dunque. L'ex
presidente della Repubblica - che conosceva Curioni dagli anni in cui il
monsignore lavorava come cappellano al carcere di San Vittore e in cui Scalfaro
lavorava come magistrato alla Corte d'Assise di Novara - dimostrò anche in altre
occasioni di avere una certa predisposizione a prestare attenzione a quel canale
naturale di mediazione con il mondo della criminalità che era l'universo dei
cappellani.
E prima del rapporto con Fabbri e Curioni, Scalfaro
innescò altre simil-trattative anche negli anni in cui prestò servizio come
ministro dell'Interno (1983-1987): quando cioè, per esempio, non fece mistero di
considerare "una sua persona di fiducia" un personaggio divenuto famoso negli
anni del terrorismo rosso come suor Teresilla. Suor Teresilla, forse qualcuno lo
ricorderà, negli anni Ottanta si affermò come uno dei canali di comunicazione, e
di trattativa appunto, tra il mondo delle istituzioni e il mondo delle Brigate
rosse. Suor Teresilla, all'epoca, pur essendo criticata da alcuni magistrati che
vedevano in lei il simbolo di una pericolosa contiguità tra lo stato e le Br, fu
sempre molto rispettata, e anche quando negli anni Novanta divenne a tutti gli
effetti "referente dei terroristi rossi" (fu a lei che il brigatista Valerio
Morucci, protagonista del rapimento di Moro, consegnò il suo memoriale, nel
1990, affinché lo facesse avere al presidente della Repubblica Francesco
Cossiga) a nessuno passò mai per la testa di attaccarla in quanto "simbolo di un
cedimento dello stato" nei confronti del terrorismo rosso. Anzi, quando anni
dopo Teresilla venne travolta e uccisa da un pirata della strada (2005), anche
giornali solitamente schierati contro ogni forma possibile ed esistente di
trattativa decisero di descrivere Teresilla non come una spregiudicata
mediatrice tra lo stato e le Br ma come (scrisse Repubblica) "una donna
avventurosa che si è fatta strumento in carne e ossa di riscatto e
riconciliazione maneggiando segreti di stato e domande di grazia". "Francamente
- dice don Fabbri, oggi relegato dalla chiesa nella sua piccola parrocchietta
senese - io credo che l'accezione dolosa che i pm danno alla parola ‘trattativa'
derivi dal fatto che alcune persone si sono messe in testa di riscrivere a loro
piacimento la storia d'Italia non per trovare e scoprire la ‘verità' ma per
dimostrare più che altro le proprie teorie o le proprie personali visioni del
mondo".
Don Fabbri oggi è dunque prudente nel maneggiare la
parola "trattativa" rispetto agli infuocati anni Novanta, e sul tema in
questione segue la stessa linea adottata dal generale Mario Mori: non ci fu
alcuna trattativa segreta tra la stato e la mafia ma vi furono semplicemente dei
contatti trasparenti e alla luce del sole di alcuni rappresentanti delle
istituzioni con alcuni "rappresentanti della criminalità" (per esempio Mori con
Vito Ciancimino nel 1992, quando il generale cercò di portare l'ex sindaco
mafioso di Palermo sulla strada del pentimento) e di alcuni "rappresentanti
della criminalità" con alcuni esponenti delle istituzioni (per esempio i
carcerati mafiosi con il mondo dei cappellani, del Dap e indirettamente dunque
con le stesse istituzioni).
Riavvolgendo però il nastro e tornando agli anni in cui
per la prima volta venne testata la solidità della rete diplomatica costruita
dai cappellani, Fabbri ammette che effettivamente in un'occasione del tutto
particolare lo stato e la chiesa fecero insieme affidamento proprio su di loro
(alla coppia Fabbri-Curioni) per provare a impostare quella che oggi lo stesso
cappellano senese non ha difficoltà a definire la "grande trattativa". Il nastro
va dunque riavvolto al 1978 e ai giorni immediatamente successivi al rapimento
di Aldo Moro. Ai tempi, Curioni e Fabbri si erano da poco insediati al
coordinamento dei cappellani delle carceri e appena due anni dopo l'ingresso
formale al terzo piano di Via Giulia (doveva aveva sede l'ufficio dei due
cappellani) a un certo punto squillò il telefono e dall'altra parte della
cornetta Curioni si ritrovò lo storico braccio destro di Paolo VI: don Pasquale
Macchi, segretario di stato. Siamo a fine marzo: Aldo Moro è stato rapito da
pochi giorni dalle Br e la Chiesa decise di organizzarsi per dare il suo
contributo a una possibile trattativa. Lo fece su due fronti: da un lato con
l'attività singola del famoso don Antonello Mennini (il prete che si dice
avrebbe persino ricevuto dai brigatisti il via libera a confessare Moro prima di
essere ucciso) e dall'altro con la coppia Fabbri-Curioni. "Accadde tutto
all'improvviso - ricorda Fabbri - Don Macchi telefonò a Curioni, gli disse che
il Santo Padre voleva intervenire, gli spiegò che Montini era convinto che la
malavita con cui noi cappellani eravamo venuti a contatto potesse sapere
qualcosa di importante e ci chiese così, direttamente, di cercare un canale per
arrivare a Moro. In un primo momento, ci limitammo ad attivare i nostri
contatti, e ci spostammo a lungo nel carcere di San Vittore, dove Curioni aveva
delle ottime fonti; e proprio le fonti di Curioni ci diedero la possibilità di
mettere per primi le mani sulle famose foto di Moro, quella con il lenzuolo
rosso con la stella a cinque punte dietro la schiena di Moro e quella con una
copia della Repubblica in mano datata 19 marzo 1978. Dopo di che, pochi giorni
prima che l'ex presidente del Consiglio venisse ucciso, ci fu una piccola
svolta: ci rendemmo conto che forse una soluzione era possibile, e che era
possibile liberare Moro: fu in quel momento che don Macchi parlò con Curioni e
ci convocò direttamente a Castel Gandolfo, a casa del Santo Padre".
E lì Fabbri vide qualcosa di clamoroso che non aveva mai
raccontato prima d'ora. "Era il pomeriggio del 6 maggio 1978 e a un certo
punto, quando arrivammo da Montini, il Papa ci accompagnò nel suo studio
privato, ci fece avvicinare a una gigantesca consolle coperta da un lenzuolo
azzurro, e poi, lo ricordo perfettamente, con un rapido gesto della mano sollevò
il lenzuolo e ci mostrò, ben disposte sulla consolle, una serie infinita di
mazzette di dollari messe una accanto all'altra. ‘Sono dieci milioni di
dollari', ci disse Montini, e ci spiegò che quelli erano soldi che la chiesa
aveva messo a disposizione per pagare il riscatto di Moro. Non fu sufficiente,
però: qualcosa che non abbiamo mai capito successe nei giorni successivi e quei
soldi purtroppo non arrivarono mai a chi dovevano arrivare".
Trattative, trattative, trattative.
Ché in fondo il senso della storia di don Fabbri (e di
riflesso di don Curioni, morto nel 1996) questo è: un modo diverso di leggere
gli "anni delle trattative", un modo diverso di raccontare quello che alcuni
magistrati definiscono "il patto delle istituzioni con le cosche" e un modo
diverso di esplicitare un piccolo dubbio che alcuni giorni fa è saltato persino
all'occhio del solitamente rigidissimo procuratore capo della procura di
Palermo: quel Francesco Messineo che lo scorso 14 giugno non ha messo la propria
firma in calce all'atto di notifica della conclusione delle indagini "sulla
trattativa stato-mafia" (atto firmato da Nino Di Matteo e Antonio Ingroia)
motivando indirettamente la sua scelta qualche giorno prima durante un'audizione
di fronte all'Antimafia, quando Messineo, ignorato da quasi tutti i giornali, a
proposito delle "volontà trattativiste delle istituzioni" scelse più o meno le
stesse parole utilizzate da don Fabbri in questa chiacchierata. "Se per
trattativa si vuole intendere una formale trattativa con plenipotenziari seduti
ai lati del tavolo, questo non vi fu certamente", disse Messineo, ammettendo
poi, sempre a proposito di trattativa, che qui "si potrebbe parlare di una
ragion di stato interpretata da pochi soggetti, secondo loro particolari
orientamenti e secondo una loro particolare visione, nell'intento - in sé
astrattamente lodevole - di prevenire le stragi". Lodevole, già. E chissà che
allora anche le parole di Messineo messe a fianco a quelle di don Fabbri non
siano lì a testimoniarci che, a voler guardar bene, la storia sulla
temibilissima "trattativa stato-mafia" in fondo è un caso già chiuso da tempo.
Claudio Cerasa (Il Foglio 16 luglio 2012)
|