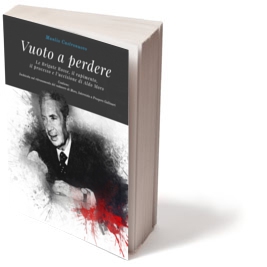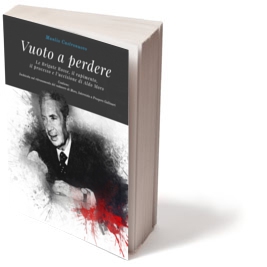|
|
'Così torturavamo i brigatisti'
Usare ogni mezzo per far parlare i terroristi: era il 1982 quando l'Espresso
denunciò le sevizie ai responsabili per il sequestro Dozier. All'epoca il nostro
cronista fu smentito e arrestato. Oggi il commissario di polizia Savatore Genova
conferma tutto: 'Ero tra i responsabili, e ricevemmo il via libera per botte e
sevizie"
Sì, sono anche io responsabile di quelle torture. Ho usato le maniere forti
con i detenuti, ho usato violenza a persone affidate alla mia custodia. E,
inoltre, non ho fatto quello che sarebbe stato giusto fare. Arrestare i miei
colleghi che le compivano. Dovevamo arrestarci l'un con l'altro, questo dovevamo
fare". Salvatore Genova è l'uomo il cui nome è da trent'anni legato a una grigia
vicenda della nostra storia recente. Quella delle torture subite da molti
terroristi tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta.
Una vicenda grigia perché malgrado il convergere di testimonianze
concordanti, le denunce di poliziotti coraggiosi e le inchieste giudiziarie la
verità non è mai stata accertata. Nessuna condanna definitiva, nessuna
responsabilità gerarchico-amministrativa, nessuna responsabilità politica. Solo
lui, il commissario di polizia Salvatore Genova, e quattro altri poliziotti
arrestati con l'accusa di aver seviziato Cesare Di Lenardo, uno dei cinque
carcerieri del generale americano James Lee Dozier, sequestrato dalle Brigate
rosse il 17 dicembre 1981 e liberato dalla polizia il 28 gennaio 1982. Evocare
il nome di Genova vuol dire far tornare alla memoria l'acqua e sale ai
brigatisti, le sevizie, le botte.
Oggi Salvatore Genova non ci sta più. Nel 1997 aveva iniziato a mandare al
ministero informative ed esposti senza avere risposte. Adesso ha deciso di fare
nomi, indicare responsabilità, svelare quello che accadde davvero in quei giorni
drammatici. Ecco il suo racconto. "Questura di Verona, dicembre 1981. Il
prefetto Gaspare De Francisci, capo della struttura di intelligence del Viminale
(Ucigos) convoca Umberto Improta, Salvatore Genova, Oscar Fioriolli e Luciano De
Gregori. E' la squadra messa in campo dal ministero dell'Interno (guidato dal
democristiano Virginio Rognoni) per cercare di risolvere il caso Dozier.
Il capo dell'Ucigos, De Francisci, ci dice che l'indagine è delicata e
importante, dobbiamo fare bella figura. E ci dà il via libera a usare le maniere
forti per risolvere il sequestro. Ci guarda uno a uno e con la mano destra
indica verso l'alto, ordini che vengono dall'alto, dice, quindi non
preoccupatevi, se restate con la camicia impigliata da qualche parte, sarete
coperti, faremo quadrato. Improta fa sì con la testa e dice che si può stare
tranquilli, che per noi garantisce lui. Il messaggio è chiaro e dopo la riunione
cerchiamo di metterlo ulteriormente a fuoco. Fino a dove arriverà la copertura?
Fino a dove possiamo spingerci? Dobbiamo evitare ferite gravi e morti, questo ci
diciamo tra di noi funzionari. E far male agli arrestati senza lasciare il
segno.
Il giorno dopo, a una riunione più allargata, partecipa anche un funzionario
che tutti noi conosciamo di nome e di fama e che in quell'occasione ci viene
presentato. E' Nicola Ciocia, primo dirigente, capo della cosiddetta squadretta
dei quattro dell'Ave Maria come li chiamiamo noi. Sono gli specialisti
dell'interrogatorio duro, dell'acqua e sale: legano la vittima a un tavolo e,
con un imbuto o con un tubo, gli fanno ingurgitare grandi quantità di acqua
salata. La squadra è stata costituita all'indomani dell'uccisione di Moro con un
compito preciso. Applicare anche ai detenuti politici quello che fanno tutte le
squadre mobili. Ciocia, va precisato, non agì di propria iniziativa. La
costituzione della squadretta fu decisa a livello ministeriale.
Ciocia, che Umberto Improta soprannomina dottor De Tormentis, un nomignolo
che gli resta attaccato per tutta la vita, torna a Verona a gennaio, con i suoi
uomini, i quattro dell'Ave Maria. Da più di un mese il generale è prigioniero,
la pressione su di noi è altissima.
Il 23 gennaio viene arrestato un fiancheggiatore, Nazareno Mantovani.
Iniziamo a interrogarlo noi, lo portiamo all'ultimo piano della questura. Oltre
a me ci sono Improta e Fioriolli. Dobbiamo "disarticolarlo", prepararlo per
Ciocia e i quattro dell'Ave Maria. Lo facciamo a parole, ma non solo. Gli usiamo
violenza, anche io. Poi bisogna portarlo da Ciocia in un villino preso in
affitto dalla questura. Lo facciamo di notte. Lo carichiamo, bendato, su una
macchina insieme a quattro dei nostri. Su un'altra ci sono Ciocia con i suoi
uomini, incappucciati. Fioriolli, Improta e io, insieme ad altri agenti, siamo
su altre due macchine. Una volta arrivati Mantovani viene spogliato, legato mani
e piedi e Ciocia inizia il suo lavoro con noi come spettatori. Prima le minacce,
dure, terrorizzanti: "Eccoti qua, il solito agnello sacrificale, sei in mano
nostra, se non parli per te finisce male". Poi il tubo in gola, l'acqua
salatissima, il sale in bocca e l'acqua nel tubo. Dopo un quarto d'ora Mantovani
sviene e si fermano. Poi riprendono. Mentre lo stanno trattando entra il capo
dell'Ucigos, De Francisci, e fa smettere il waterboarding.
Dopo qualche giorno l'interrogatorio decisivo che ci porterà alla liberazione
di Dozier, quello del br Ruggero Volinia e della sua compagna, Elisabetta
Arcangeli.
Io sono fuori per degli arresti e quando rientro in questura vado all'ultimo
piano. Qui, separati da un muro, perché potessero sentirsi ma non vedersi, ci
sono Volinia e la Arcangeli. Li sta interrogando Fioriolli, ma sarei potuto
essere io al suo posto, probabilmente mi sarei comportato allo stesso modo. Il
nostro capo, Improta, segue tutto da vicino. La ragazza è legata, nuda, la
maltrattano, le tirano i capezzoli con una pinza, le infilano un manganello
nella vagina, la ragazza urla, il suo compagno la sente e viene picchiato
duramente, colpito allo stomaco, alle gambe. Ha paura per sé ma soprattutto per
la sua compagna. I due sono molto uniti, costruiranno poi la loro vita insieme,
avranno due figlie.
E' uno dei momenti più vergognosi di quei giorni, uno dei momenti in cui
dovrei arrestare i miei colleghi e me stesso. Invece carico insieme a loro
Volinia su una macchina, lo portiamo alla villetta per il trattamento. Lo
denudiamo, legato al tavolaccio subisce l'acqua e sale e dopo pochi minuti
parla, ci dice dove è tenuto prigioniero il generale Dozier. Il blitz è un
successo, prendiamo tutti e cinque i terroristi e li portiamo nella caserma
della Celere di Padova. Ciascuno in una stanza, legato alle sedie, bendato, due
donne e tre uomini. Tra loro Antonio Savasta che inizierà a parlare quasi
subito, e proprio con me, consentendoci di fare centinaia di arresti.
Ma le violenze non finiscono con la liberazione del generale. Il clima è
surriscaldato. Tutti sanno come abbiamo fatto parlare Volinia e scatta
l'imitazione, il "mano libera per tutti". Un gruppo di poliziotti della celere,
che si autodefinisce Guerrieri della notte, quando noi non ci siamo, va nelle
stanze dove sono i cinque brigatisti e li picchia duramente. Un ufficiale della
celere, uno di quei giorni, viene da me chiedendomi se può dare una ripassata a
"quello stronzo", riferendosi a Cesare Di Lenardo, l'unico dei cinque che non
collabora con noi. Io non gli dico di no e inizia in quell'attimo la vicenda che
ha portato al mio arresto. La mia responsabilità esiste ed è precisa, non aver
impedito che il tenente Giancarlo Aralla portasse Di Lenardo fuori dalla
caserma. La finta fucilazione e quello che accadde fuori dalla caserma lo
sappiamo dalla testimonianza di Di Lenardo. Io rividi il detenuto alle docce.
Degli agenti stavano improvvisando su di lui un trattamento di acqua e sale. Li
feci smettere ma non li denunciai diventando così loro complice.
La voglia di emulare, di menar le mani, di far parlare quegli "stronzi" non
si ferma a Padova. Di Mestre so per certo. Al distretto di polizia vengono
portati diversi terroristi arrestati dopo le indicazioni di Savasta. I
poliziotti si improvvisano torturatori, usano acqua e sale senza essere
preparati come Ciocia e i suoi, si fanno vedere da colleghi che parlano e
denunciano. Ma l'inchiesta non porterà da nessuna parte. Quando i giornali
cominciano a parlare di torture e scatta l'indagine contro di me e gli altri per
il caso Di Lenardo mi faccio vivo con Improta, gli dico che non voglio restare
con il cerino in mano, che devono difendermi. Lui promette, dice di non
preoccuparmi, ma solo l'elezione al Parlamento propostami dal Partito
socialdemocratico mi toglie dal processo. Gli altri quattro arrestati con me
vengono condannati in primo grado e, alla fine, amnistiati.
Noi non siamo mai stati in prigione. Io venni portato all'ospedale militare
di Padova e lì mi venivano a trovare funzionari di polizia per informarmi delle
intenzioni dei magistrati. Tra le mie carte ho ritrovato un appunto
dattiloscritto che mi venne consegnato in quei giorni. E' una falsa, ma
dettagliatissima, ricostruzione dei fatti che dovevamo sostenere per essere
scagionati. Suppongo che lo stesso foglio venne dato anche agli altri arrestati
perché non ci fossero contraddizioni tra di noi. Io me ne sono restato buono per
tutti questi anni perché non volevo far scoppiare lo scandalo, fare arrestare
tutti quanti.
Oggi, guardandomi indietro, vedo con chiarezza che ho sbagliato, che non
avrei dovuto commettere quelle cose, né consentirle. Non dovevo farlo né come
uomo né come poliziotto. L'esperienza mi ha insegnato che avremmo potuto
ottenere gli stessi risultati anche senza le violenze e la squadretta dell'Ave
Maria".
di Pier Vittorio Buffa (05/04/2012, L'Espresso)
|