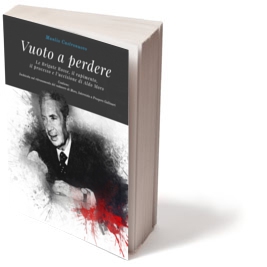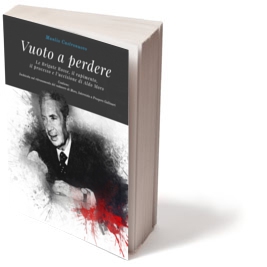|
|
Le "rivelazioni" di Sofri su quel che già si sapeva:
gli "Affari riservati" del Viminale erano una centrale di provocazione e di
illegalità
(Il Foglio, 29 maggio 2007)
Un po’ più di cinque anni dopo il 12 dicembre
1969 di piazza Fontana, rinominato (e anestetizzato) ormai ufficialmente Strage
di stato, Federico Umberto D’Amato, già responsabile dell’ufficio Affari
riservati, il più noto e influente titolare dei servizi italiani nel dopoguerra,
mi chiese un incontro, tramite un conoscente comune, accampando una ragione
privata. Non avendo io, né allora né mai, motivo per rifiutare di vedere
qualcuno, consentii: trattandosi di un colloquio privato, e chiesto da lui, si
sarebbe svolto a casa mia. Una sera D’Amato venne a casa mia.
Era un vecchio appartamento in un vicolo del
rione Monti, che definire modesto è già troppo benigno, in cui abitai dal 1973
al 1976 con Randi, cani, e un perenne viavai di persone, come usava. D’Amato
salutò galantemente Randi, che si sbrigò a lasciarci soli, e lo stesso fece il
suo accompagnatore. La conversazione si trastullò per un po’, con un certo
impegno da parte sua, uomo che sapeva (fin troppo) stare al mondo, e che sapeva
ancor meglio che cosa Lotta continua pensasse e scrivesse di lui.
Meno impegnato, io consideravo quel
balzacchiano gastronomo dall’eloquio forbito, dalla faccia irreparabile e dal
profumo di barbiere. Mi sembrò che per un po’, come succede in certe
circostanze, volesse mostrarsi persona di cultura. Avendolo io interrotto su un
anello che spiccava su una mano assai curata, così madornale da sembrare
d’ordinanza, me ne spiegò il legame – se la memoria non m’inganna – con la morte
di sua moglie, e il fresco dolore che ne provava.
Quando lo invitai a venire al suo proposito, mi
disse, con la stessa amabile naturalezza, che si trattava dei Nap, i Nuclei
armati proletari. Che tutti sapevano come alcuni fra i loro membri avessero
rotto con Lc accusandola di non voler passare alla lotta armata. Che erano
pochi, che avrebbero continuato a seguire la loro natura di criminali comuni,
contro lo stato, ma anche nuocendo gravemente a noi e al movimento in cui ci
riconoscevamo. Che la normale repressione ne sarebbe venuta a capo, ma chissà in
quanto tempo e dopo quanti guasti.
Che era dunque interesse comune toglierli
fisicamente di mezzo (“Fisicamente?” “Fisicamente!”), ciò che avrebbe potuto
avvenire con una mutua collaborazione e la sicurezza dell’impunità. Prima che
finisse gli avevo indicato la porta, e lui la prese senza battere ciglio. Dunque
quel signore non mi propose di prender parte a un omicidio, ma, seppure in un
linguaggio da dopobarba, e senza avere il tempo di entrare nel dettaglio, un
mazzetto di omicidi.
Quel linguaggio, e la brusca fine
dell’intrattenimento, mi impediscono ancora oggi di decidere a che cosa davvero
mirasse, benché comunque la provocazione fosse spettacolosa. Ecco. Misi a parte
dell’episodio poche persone, che fossero in grado di capire e rispondere se la
cosa avesse avuto seguiti imprevedibili. Non ne parlai pubblicamente: non avevo
prove del tema (io non avevo congegni spionistici, forse lui sì) e nella
pubblicità poteva magari risiedere la provocazione. Soprattutto, a parte
l’impudenza, non c’era niente che fosse capace di meravigliarci nell’operato di
D’Amato e dei suoi uffici: e caso mai è grossa che qualcuno mostri di
meravigliarsene oggi.
Ci fu, qualche tempo dopo, una circostanza
tragicomica: un paio di persone, che erano state a me molto legate, avevano
aderito ai Nap e mi rinfacciavano di non approvare e anzi di non capeggiare la
loro guerra – si leggevano i “Cent’anni di solitudine” in carcere, e io ero
stato l’Aureliano Buendia dei loro sogni – mi tesero una specie di agguato alle
porte di casa, che si tramutò in un parapiglia e poi si accontentò di uno
scambio di insulti e di accenni di rimpianto.
Ripetei loro ancora una volta, e a ragion più
veduta, quello che mi ero sforzato di dire dall’inizio della loro impazienza:
che andavano allo sbaraglio, che lo stato giocava con loro come il gatto col
topo, che avrebbero fatto male alla loro causa e perduto se stessi. Le stesse
cose che si leggono sulle pagine del nostro giornale di allora. Fu quello che si
consumò nella breve stagione dei Nap, autori di azioni sanguinose, e manovrati e
trucidati senza scampo.
Fra loro persone specialmente generose,
trascinate oltre e contro le proprie convinzioni da una solidarietà invincibile
di compagni di galera e di lotta. Così, già nel 1974, il giovane Sergio Romeo e
Luca Mantini in una rapina fiorentina seguita, se non promossa, dalle forze
dell’ordine, e lasciata svolgere fino all’uccisione dei suoi autori. Così nella
tragedia della sorella di Mantini. Così nell’attentato romano culminato nel
“fuoco amico” che uccide Martino Zicchitella nel 1976. Così nell’esecuzione di
Antonio Lo Muscio nel 1977. Questo dunque l’episodio cui avevo fatto cenno.
“Perché ora?” Perché ora ho scritto a proposito di una memoria che, avendo
lodevolmente cura di rendere giustizia a persone ed eventi trascurati o offesi o
calunniati, inclina a una opposta deformazione.
Ho ricordato, benché non ce ne fosse bisogno,
che lo stato di quegli anni Sessanta e Settanta aveva uomini e organi capaci di
ogni illegalità e di veri crimini. Io non sono attaccato alle formule
sistematrici, e piuttosto ne diffido: non sono affar mio né il “doppio stato”,
né le “deviazioni”, né altre semplificazioni di una gran porcheria durata troppo
a lungo. La mia “rivelazione” non rivela niente di più di quello che è evidente
per mille prove: per me, fu un personale saggio di quello che sapevo.
D’Amato è morto, da dieci anni. Come succede,
molti – troppi – lo protessero e ne furono protetti, a destra (soprattutto) ma
anche a sinistra, e probabilmente strada facendo dimenticarono, come conviene, a
chi convenisse. Ebbe anche lui parecchie vite, e molti lo frequentarono, anche
persone degnissime, e trovarono delle buone e piacevoli ragioni per farlo: il
mio carissimo amico Federico Bugno, per esempio, collega suo all’Espresso e
compagno di gusti letterari e culinari. Resta che se con ogni uomo che muore è
un’intera biblioteca che scompare, con D’Amato se n’è andato un intero archivio:
e anzi, siccome non ci stava tutto, sepolto lui furono lasciati alla rinfusa
nella via Appia 150 mila fascicoli non catalogati…
Adriano Sofri
|