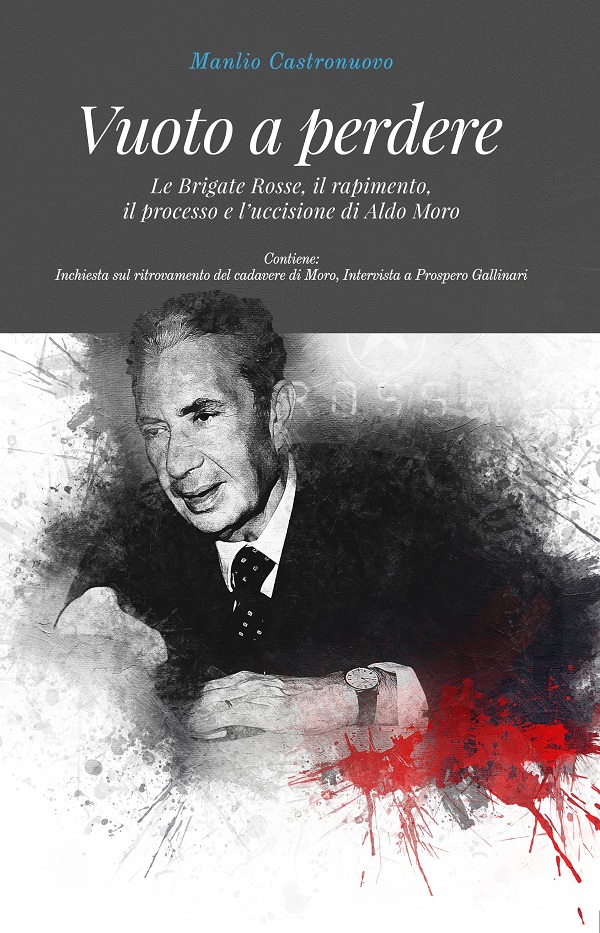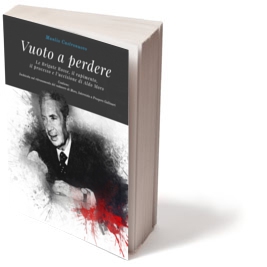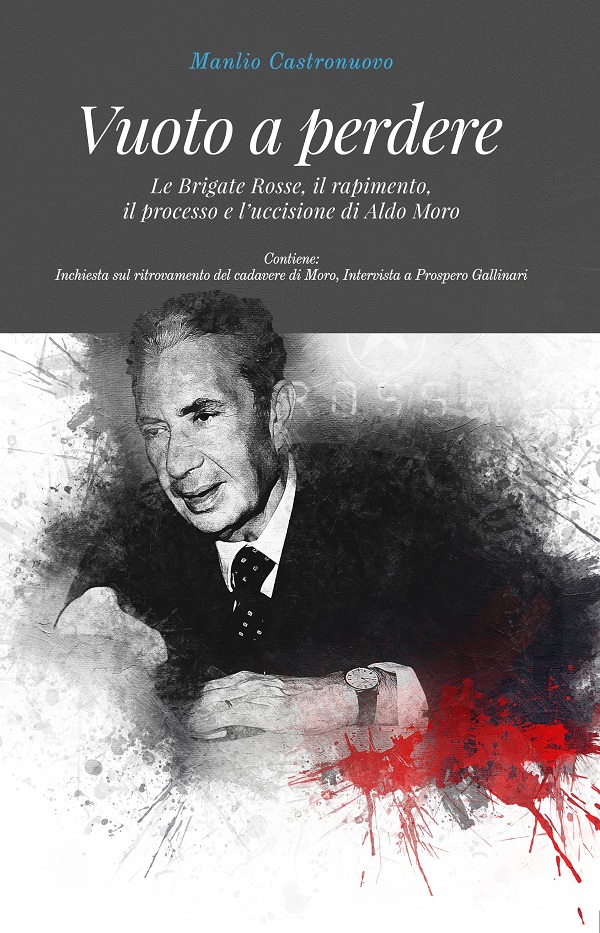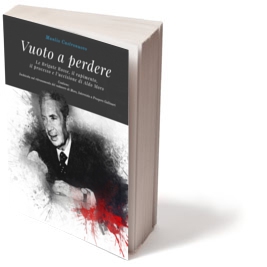|
|
Calabresi e Pinelli gemelli diversi
Napolitano che piange sul lutto versato, due vedove di opposte storie che
s’incontrano, tante ombre del passato che popolano il deserto variopinto del
presente. L’Italia in bianco e nero, l’Italia cupa degli anni Settanta e della
guerra civile, non vuole sparire: torna a visitarci con cadenza quasi
quotidiana, e attraversa le istituzioni e i tribunali, i media e i libri. Torna
con Pansa, torna con le memorie dei suoi protagonisti e testimoni, torna con le
cerimonie al Quirinale, con il capo dello Stato che si commuove per Pinelli, non
per Calabresi (ma al cuor, come alle lacrime, non si comanda). E torna ora con
il libro di Giampiero Mughini, Gli anni della peggio gioventù, che uscirà con
Mondadori la prossima settimana.
È ancora il caso Calabresi che ritorna, e con lui torna Lotta continua;
sterminata memorialistica di Sofri e di Marino, di Mario Calabresi e di Aldo
Cazzullo, più una folta pattuglia di vip, che furono ex di Lotta continua. Anche
Mughini è un ex compagno in borghese: prestò la sua firma a Lotta continua e pur
nel disincanto dei decenni seguenti, continuò a difendere Sofri da chi lo voleva
assassino e in carcere. Ma la verità, a cui Mughini ha dedicato il libro, lo
spinge a riconoscere la responsabilità di Sofri e a confermare che il delitto
Calabresi fu partorito dalle viscere di Lotta continua.
La ricostruzione del clima di odio
Sì, lo so, per noi forse era già evidente, troppe sentenze di ogni grado lo
hanno poi confermato; e quelle righe di condanna a morte del Commissario che
apparvero su Lotta continua erano già chiare e brucianti come il sole. E un
magistrato di sinistra come Gerardo D’Ambrosio aveva già assolto Calabresi dalla
morte di Pinelli. Ma l’onestà di Mughini lo porta a cancellare residue
reticenze, affettuose dimenticanze, e a ricostruire con rigore giornalistico
quel delitto e quel clima. E lo porta anche a ricordare quanti avevano sposato
il teorema di Calabresi assassino, quanti avevano poi brindato alla sua
uccisione, quanti hanno dimenticato e negato le colpe di Lotta continua nel
clima di violenza e di terrore; ricorda gli assalti alle sedi della Dc e dell’Msi,
le accuse assurde ad Almirante, Rauti e Pisanò, i comizi di limpide figure come
Beppe Niccolai impediti con la forza, come quella fatidica sera a Pisa.
No, non vi farò la solita storia di quegli anni, ho nausea anch’io a
ripeterla, non riscriverò quei nomi ancora egemoni, mi vergogno per loro. E non
mi addentrerò nella ricostruzione minuziosa di Mughini, che lascio ai lettori
del suo libro. Farò piuttosto tre o quattro considerazioni di più lungo raggio,
che entrano nel nostro presente.
La prima, forse più sorprendente, è che non condivido del tutto la tesi di
Mughini dell’inesistenza di una responsabilità di Stato in quegli anni feroci.
No, al di là delle dietrologie, delle stragi di Stato e del doppio Stato, di cui
si chiacchiera, ci fu in quegli anni una brutta piega dei corpi deviati, che
andò ben al di là dei lavori sporchi che devono pur fare i servizi segreti. Quel
capitolo che va da piazza Fontana al caso Moro, da Ustica a Pecorelli e altro,
non è un’invenzione dei dietrologi, c’è qualcosa di vero nell’uso alternato di
anarchici e nazisti, di terroristi rossi e neri, e forse di mafiosi, da parte
degli apparati di Stato. Per carità, nessun complotto, ma non credo
all’innocenza di Stato e di alcuni ministri e presidenti. Cosa che, ovviamente,
non sminuisce di un grammo il terrorismo e le sue colpe.
In secondo luogo, dobbiamo chiederci quanto pesano ancora oggi quegli anni
atroci, quei delitti, quelle criminalizzazioni. Non sono tra quelli che
auspicano di inchiodare alle loro responsabilità gli ottocento firmatari contro
Calabresi, i vecchi lottacontinuisti e via dicendo. Basta, il tempo è passato,
ed estendo la clemenza dello sguardo anche a Sofri. Ma provo ancora schifo a
pensare che quei teoremi, quell’intolleranza, quelle chiusure hanno pesato e
ancora pesano su chi era dalla parte opposta. Altri Pinelli e altri Calabresi
furono dimenticati, idealisti di un’opposta utopia o gente che fece il proprio
dovere e fu linciata. E ancora oggi, altre voci come quelle aggredite da Lotta
continua, sono impossibilitate a esprimersi all’Università, in piazza, nella
stampa. Ieri sprangavano oggi silenziano.
L’assassinio Gentile e i conti col passato
In terzo luogo, il libro di Mughini fa un paragone critico tra l’assassinio
di Gentile e quello di Calabresi per biasimare chi considera i killer di
Calabresi sullo stesso piano degli assassini di Gentile. È di questi giorni la
sentenza di un magistrato che reputa diffamatorio definire assassino chi uccise
il grande filosofo. «Fu un atto di guerra», dice; ma Gentile non era in armi,
era uomo di pace e aveva quasi settant’anni. La sentenza fa il paio con
l’assurdo che ci sono vie dedicate a chi uccise o concorse all’uccisione di
Gentile, vale a dire il comunista Bruno Fanciullacci, e non ci sono vie o atenei
dedicati al più grande filosofo italiano del Novecento, al grande riformatore
della scuola e dell’Università, al grande fondatore dell’Enciclopedia Italiana.
Ed è squallido notare che alcuni intellettuali comunisti, di sinistra e finiani,
reputano “moralistico” stigmatizzare l’assassinio di Gentile.
Il caso Gentile, ormai vecchio di 65 anni, dimostra che i conti con il
passato e con la verità non li abbiamo ancora fatti e non si intravede ancora il
tempo in cui li faremo. Perciò cari Mughini e Pansa, venuti da sinistra, vi
toccherà ancora scavare in quel passato e raccontare. Fatelo voi perché noi, io
perlomeno, ho nausea, sono stanco di ascoltare e ripetere queste cose, non ho
più voglia di bianco e nero, che mi fa schifo quanto il grigiore del presente.
A proposito, ho un sussulto di nostalgia per anarchici come Pinelli e
servitori dello Stato come Calabresi. Credevano in qualcosa e rischiavano di
persona. Come sono lontani anni luce...
Marcello Veneziani (LiberoNews.it, 16 maggio 2009)
|