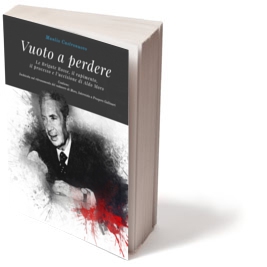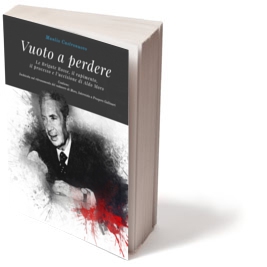|
|
«Mio padre Guido Rossa e la sua lotta solitaria»
Vede quella stanza lassù, al secondo piano? Quella mattina stavo là, avevo
sedici anni. Secondo anno di istituto magistrale. I miei compagni erano tutti in
strada, pensavo ci fosse una delle solite assemblee, ce n’erano di continuo
allora. Io andai in classe. Venne la mia insegnante di inglese, mi poggiò una
mano sulla spalla e mi disse “devi andare a casa, tuo padre ha avuto un
incidente”. Non capivo perché dovesse accompagnarmi la madre di una mia amica.
“Conosco la strada”, risposi. Lei mi fece salire in macchina e fece il tragitto
più lungo». Un giro tortuoso per non passare lungo via Fracchia.
Era il 24 gennaio 1979 e il cielo di Genova era nuvoloso, «proprio come
oggi», spiega Sabina Rossa,deputata Pd, figlia di Guido, sindacalista Italsider
prima gambizzato e poi finito con un colpo al cuore dalle Brigate rosse. Il
primo operaio ucciso dai terroristi. Lo aspettarono sotto casa, lui se ne
accorse, salì in macchina di corsa, tentò di proteggersi, non servì a nulla.
«Uscii per andare a scuola, passai accanto alla macchina di mio padre, ma non la
vidi, non vidi il suo corpo riverso sul volante. Ancora oggi quello rimane il
mio cruccio più grande. Se ne accorse lo spazzino». Sabina sceglie di parlare
mentre cammina per le strade della città. Tre ore per tracciare un percorso che
soltanto alla fine si svela per quello che è stato: il percorso della sua vita,
da quel giorno di 30 anni fa. Via Fracchia è sulle alture di Genova. La casa in
cui è cresciuta sta al civico 4: è tutto come allora, la facciata rosa, il
cortile. Sua madre, Maria Silvia, vive ancora lì. «Quando arrivai vidi
poliziotti, carabinieri, tanta gente. Mia madre si avvicinò, disse “hanno
ammazzato tuo padre”».
«Aveva denunciato alla vigilanza dell’Italsider i suoi sospetti su un operaio
che diffondeva volantini dei terroristi. Erano in molti ad avere sospetti su
Francesco Berardi, “il postino delle br”, ma alla fine soltanto mio padre firmò
la denuncia. Il perché all’inizio non riuscivo a capirlo. Poi, dopo molti anni,
riaprendo quel capitolo doloroso della mia vita, ho imparato a conoscerlo di
più: sapeva che le Br cercavano fiancheggiatori tra gli operai, volevano creare
colonne nelle fabbriche. Aveva capito chi era che diffondeva materiale all’Italsider
e si era assunto la responsabilità di parlarne con la vigilanza. Oggi so per
certo che in molti sapevano dell’attività del postino, ma nessuno volle esporsi
e quando mio padre ne parlò, chiamarono i carabinieri e gli fecero firmare una
deposizione mettendo nero su bianco. Poi, chissà come mai il nome di Guido Rossa
finì su tutti i giornali, si buttò in pasto alle Br. Non gli fu mai data una
scorta, si offrirono i suoi compagni, ma lui rifiutò perché sapeva che avrebbe
messo a rischio altre vite. Eppure gli inquirenti sapevano della colonna
“inviolata”genovese». Dieci morti e decine di feriti in pochi anni.
Oggi al posto dell’istituto magistrale c’è una scuola materna. Cento metri
più avanti c’è il liceo artistico «Grazia Deledda». «Come ce l’ho fatta?
Rimuovendo tutto. Mi ha aiutato lo sport. Pregai mia madre di iscrivermi ad un
corso di paracadutismo». Anche Guido Rossa era un paracadutista, «forse mi ha
trasmesso lui questa passione». Lo sport, l’Isef, la laurea in Scienze motorie,
«mi hanno portato qui, al Deledda, dove ho iniziato a insegnare». Mostra «Guido
Rossa, mio padre», il libro che ha scritto con Giovanni Fasanella: «Questa è una
sua foto, ritratto durante una scalata in Valle Stretta. Amava la montagna, ogni
fine settimana partiva. Poi, quando iniziò la sua attività di sindacalista
cambiò tutto». Rossa era convinto che il peggior difetto degli alpinisti fosse
la perdita di contatto con la vita reale.
«Ricordo il giorno del suo funerale: piazza dei Ferrari era piena
all’inverosimile di tute blu. Rimasi tutto il tempo su un furgoncino, vedevo
quella gente, le lacrime, i pugni alzati e gli slogan contro le Br. Guido Rossa
con la sua morte aveva segnato un punto di svolta: la classe operaia da quel
momento in poi condannò definitivamente la lotta armata, il Pci prese una
posizione netta. Fu l’inizio della fine per le Br. Per mia madre e per me, dopo
il grande affetto iniziale da parte di tutti, arrivò il vuoto, la difficoltà di
vivere con quel poco che avevamo».
Ecco Spianata Castelletto, Genova alta, vista da togliere il fiato, il porto
antico, la Lanterna, i grattacieli. «È un posto che amo molto». Gira il libro
tra le mani. «Ho deciso di scriverlo quando è nata mia figlia Eleonora. Dovevo
raccontargli chi era il nonno, ma per farlo dovevo accettare la realtà». La
rimozione andata avanti per anni. Poi, la ribellione. Salvifica. Il primo passo
è stato quello di chiamare al telefono Vincenzo Guagliardo, il brigatista che
faceva parte del commando che colpì Rossa. Fu lui a sparargli alle gambe. È un
ergastolano in semilibertà. Il terzo membro del commando, Lorenzo Carpi, è
ancora latitante. «L’ho fatto perché volevo sapere da lui come erano andate le
cose. Se era vero che lo volevano solo gambizzare e andò così per sbaglio o fu
un omicidio premeditato. Quando l’ho incontrato in una cooperativa di Melegnano,
ho capito che oggi è una persona diversa. Mi ha detto che l’ordine era di
gambizzare mio padre, che Riccardo Dura, poi ucciso durante un blitz nel covo di
via Fracchia, lo colpì al cuore di sua iniziativa».
Dopo quell’incontro è andata dal magistrato. «Ho chiesto che concedesse la
libertà a Guagliardo e il perdono non c’entra nulla con questa storia. È un
fatto di giustizia. C’è una norma, che io non condivido, in cui si stabilisce
che, dopo 26 anni di detenzione, se si instaura un contatto tra il condannato e
le vittime e si accerta un ravvedimento, il giudice può accordare la libertà.
Guagliardo non ha mai pubblicizzato il nostro incontro perché non voleva usarlo
strumentalmente. Allora ho detto io al giudice che quel ravvedimento c’era
stato». Bionda, corpo esile, carattere d’acciaio. Li ha voluti incontrare tutti
i protagonisti di quei giorni: i compagni dell’Italsider, i responsabili della
Vigilanza, il magistrato che indagò sull’omicidio, Renato Curcio, quelli che si
sono dissociati, quelli che non si sono mai pentiti, le loro compagne di vita. E
i compagni di partito. «È stato uno di loro, Lovrano Bisso, a raccontarmi che
mio padre faceva parte di una sorta di “Intelligence” del Pci ed era stato
incaricato di individuare gli “infiltrati” nelle fabbriche».
Piazza Piccapietra dista poche decine di metri dal tribunale. C’è l’unico
monumento della città a Guido Rossa. Nudo, con il dito puntato verso un
colpevole. Tre assi verticali: i mesi che trascorsero tra la sua denuncia e la
sua esecuzione. 24 ottobre-24 gennaio. «È stata realizzata con il finanziamento
degli operai dell’Italsider», racconta Sabina. Si concede una pausa, riprende.
«Guido è stato l’unico della sua famiglia a militare in un partito, suo padre
era un minatore torinese. Quando mi hanno chiesto nel ’96 di candidarmi con i Ds
ho capito che valeva la pena provare. Mi sono sempre occupata dei problemi
legati al territorio, lo sviluppo, il porto. Ma è successo qualcosa: hanno
iniziato a invitarmi in maniera incessante scuole e associazioni, chiedendomi di
parlare di mio padre. C’è una nuova generazione che chiede il conto di quello
che è successo. Se questo paese non costruisce una memoria collettiva su quegli
anni terribili non riuscirà mai a scrivere per intero quella storia». Cita Mario
Calabresi,
il figlio di Luigi. «Il ricordo dà un volto alle vittime». E aiuta tutti gli
altri «anche quelli che vengono dopo a capire».
di Maria Zegarelli (L'Unità, 21 gennaio 2009)
|