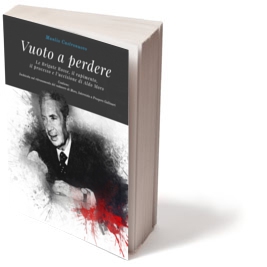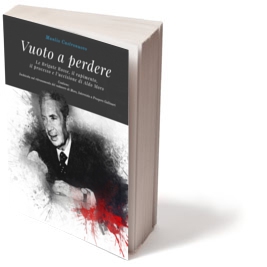|
|
La storia in faccia
Bisogna essere riconoscenti a quei giovani storici che, come Sergio Luzzatto,
scendono dalla cattedra e intervengono sui giornali per tenere ostinatamente
aperte pagine del passato recente italiano trattate spesso con troppa
disinvoltura. E che dovrebbero essere affrontate fuori da quella «mezza luce»
cui il nostro paese è così incline
Non sono contraria a un uso pubblico, e fin politico, della storia. Meglio se
fosse privato e asettico? La storia è l’esperienza delle generazioni che ci
hanno preceduto, soffriamo più di voglia di ignorarle che di farne uso. Che può
essere anche abuso, ma nessuno è più manipolabile di chi pensa che in nome del
presente possiamo cavarcela da quel che gli sta alle spalle.
Non che sia sempre gradevole ricevere la storia in faccia, una comunista
rischia di essere seppellita sotto valanghe di merda. Ieri starnazzava Pansa e
ieri l’altro il Libro nero del comunismo, ma meglio leggerli che ignorarli,
perché pescano in acque torbide fra vero e falso, fatti e proporzioni. Viva
dunque gli storici che li correggono, scendendo dalla cattedra sui giornali (e
attenzione al movimento inverso, Montanelli ha fatto scuola e se l’è cavata tra
le riverenze universali).
Uno di questi giovani storici è Sergio Luzzatto, dei cui interventi (specie
sul «Corriere della Sera» raccolti in Sangue d’Italia dalla manifestolibri) ha
già parlato in queste pagine Sandro Portelli (sul «manifesto» del 7 dicembre).
Vi ritorno perché quel fitto discorso mi ha confortato, e suscitato un problema
e una obiezione.
Usi e abusi della mezza luce
Confortante è vedere dismessa da uno storico giovane la disinvoltura con la
quale molti illustri padri della Repubblica hanno sdoganato negli anni Novanta i
fascisti. È parso a un certo momento che bisognasse essere grati a Berlusconi
perché riportava un pezzo del paese nella maggioranza e nel governo. Chi aveva
più paura del fascismo? Nessuno. Era stato un pericolo ma era finito per sempre.
Significava ignorare che se la storia non si ripete, il fascismo non è un
incidente in Europa, risponde a pulsioni profonde e ha antiche radici nella
cultura - che è un errore considerare sempre d’accatto - della destra. Si
aggiunga che l’Italia non ha fatto la durissima terapia della Germania, male
accettata dalla prima generazione postbellica ma riproposta con forza dalla
seconda. Non ci siamo sognati di costruire accanto al Vittoriale un monumento
alla Shoah come Berlino accanto alla porta di Brandeburgo, abbiamo riammesso
facilmente nell’«arco costituzionale» i nostalgici della fiamma tricolore su
bara mentre i nostalgici della svastica sembrano fuori per un pezzo da quello
tedesco.
Così i nostri ex fascisti, differentemente dagli ex comunisti, non rinnegano
il loro passato, lo selezionano. Il loro leader e presidente della Camera,
Gianfranco Fini ha definito Mussolini un grande statista e ha condannato senza
mezzi termini le leggi razziali del 1938. Ed è andato in Israele a visitare il
memoriale della Shoah, e mi è parso con emozione. Del resto è nato troppo tardi
per esserne stato coinvolto. Qualche giorno fa ha sottolineato tuttavia che non
è stato il fascismo a inventare l’antisemitismo, ma la tradizione cristiana.
Vero. Ha aggiunto che le leggi razziali non suscitarono reazioni di popolo né
nella chiesa cattolica. Vero, ma su questo avrebbe fatto meglio a tacere: quali
possibilità di reazione, che non si limitassero a nascondere qualche amico ebreo
in soffitta, c’erano nel 1938 nello stato di polizia del grande statista?
Anche il Vaticano, che ha protestato, avrebbe fatto meglio a tacere. Ha
aperto le sue porte a qualche ebreo che chiedeva asilo - come dopo il 1945 a
personaggi nazisti - ma Pio XII ha rifiutato di pronunciare una parola che forse
avrebbe fermato il raid tedesco dell’ottobre 1943 nell’ex ghetto di Roma, e
pensare che gli era stato chiesto dall’ambasciatore tedesco presso la santa
sede. Nondimeno, se la chiesa ha maledetto per secoli il popolo deicida, non ne
ha dedotto che gli ebrei erano sottouomini da sterminare. E il nostro fascismo
li ha volonterosamente deportati verso i lager del Reich non senza ammazzarne
più d’uno per strada. Tutta intera, la storia è un tessuto difficile. È la mezza
luce, cui il nostro paese è incline e della quale Renzo de Felice è stato un
attentissimo campione, che della mezza storia usa ed abusa. Ed è questo che
rende loffie le proposte di riconciliazione, di Violante e non solo. La pagina
non è chiusa - chiari e scuri della resistenza compresi - e vanno dunque
ringraziati i Luzzatto, per altri aspetti i D’Orsi e pochi altri che la tengono
ostinatamente aperta.
Un partito-giraffa
Il problema riguarda Togliatti. Ridotta all’osso - e lasciando da parte le
psicologie della persona - sarebbe stato possibile costruire un grande partito
comunista e democratico nel 1945 rompendo con l’Urss? Dico «comunista e
democratico», per bizzarro che possa sembrare oggi, perché questo è stato il Pci,
così è stato costruito e per questo ha agito tanto in profondità sulla scena del
paese. A fare storia sul serio, non credo si possa scappare da questa domanda.
Si presentò come «comunista e democratico» perché né i socialisti, né le loro
poco gloriose socialdemocrazie continentali, né gli uomini di Giustizia e
Libertà e poi Partito d’Azione avevano nel 1945 la forza sufficiente per
imprimere uno scatto decisivo al paese, una sorta di palingenesi sociale e
culturale di massa. E a quel tempo lo riconoscevano. Erano contrari ai comunisti
tutti, nel senso che non ne condividevano l’impianto più o meno classista, e
tanto meno la tesi della dittatura del proletariato, criticavano il modello
dell’Urss, ma sapevano benissimo che la leva comunista della resistenza, con cui
ebbero ad azzuffarsi, non solo non si voleva ma non era il partito bolscevico,
neppure avrebbe potuto esserlo, era una curiosa formazione e per metà classista,
uno strano animale - la «giraffa», ebbe a dire Togliatti. Tengo per fermo, e
vorrei che l’Istituto Gramsci lo avesse esaminato più a fondo, che Togliatti
abbia considerato non una disgrazia ma una occasione il fatto di trovarsi
all’ovest invece che all’est e volesse non per astuzia quella Costituzione.
Penso che sia stato sincero il suo discorso, sul filo del rasoio, contro la
duplicità e il tentativo, tutto a zig zag, del 1956-57.
Si sarebbe potuto fare un grande partito popolare denunciando l’Urss per
schierarsi con Churchill a Fulton e con gli Stati Uniti che avevano gettato le
due atomiche su Hiroshima e Nagasaki non solo né specialmente per finire il
Giappone? Non credo. Allora si ricordava ancora che l’Urss aveva avuto più di 22
milioni di morti e gli Usa erano entrati in guerra quando la Wehrmacht era
bloccata a Stalingrado. Penso che il Pci non sia stato meno circolante e aperto
alla società dell’attuale Partito democratico, meno monarchico e più severo e
pulito. Penso che il memoriale di Yalta del 1964 sia stato ben più secco e grave
del tardivo «è venuto a fine il movimento propulsivo» di Berlinguer nel 1981.
Penso che cadeva nel breve periodo nel quale né Bretton Woods era finito, né la
crisi dell’energia aperta, né Reagan e Thatcher insediati, la confusa ma grande
decolonizzazione in corso e il movimento comunista non del tutto ossificato. Per
tutti gli anni ’60 il mondo oscilla prima di attestarsi sull’ultraliberismo.
Il Pci inizia il suo declino, anche se non elettorale, allora. Quando finisce
il dopoguerra, vacilla la guerra fredda e una possibilità di terzo polo è stata
tentata. Non pretendo che sia un’ipotesi ferrea, ma certo meno approssimativa di
quella che interpreta il Pci tutto e solo nel rapporto con l’Urss, e dopo con il
crollo dell’Urss. Da quel che fu in Italia e da quel che produsse nell’idea di
sé del paese non uscì un partito che avrebbe retto alle trasformazioni degli
anni ’70 e ’80, per quel che era e anche per quel che non riuscì ad essere, ma
diverso da quella storpiatura della quale tanti ex comunisti si vergognano,
poveracci e un po’ cialtroni.
Sfoggio di buone coscienze
L’obiezione riguarda il terrorismo. Intanto non li chiamerei «terroristi» -
sovversivi, gruppi armati, omicidi. Non presero a modello Robespierre e il
Terrore, che fu un metodo di governo. E neanche i narodniki, che gettavano bombe
nel mucchio per terrorizzare; questo i brigatisti non fecero mai, a differenza
dei fascisti e le loro stragi. Se qualcuno delle Brigate Rosse ebbe in mente la
resistenza (il «gruppo reggiano dell’appartamento») non furono tutti né i più,
se ci fu un modello fu quello latinoamericano. Non erano carnefici efferati,
come si sentono in obbligo di definirli anche Luzzatto o de Luna nell’introdurre
l’interessante La piuma e la montagna (manifestolibri 2008). Le Brigate Rosse
non uccisero per uccidere, né per sfregio (eccezion fatta per Roberto Peci, e
poi ci furono crudeltà in carcere fra alcuni di loro o della stessa parte, nella
disperazione e disfatta). Il loro fu un tentativo sanguinoso di insurrezione
sbagliato, prima che dal punto di vista morale, da quello politico. Per dirla
tutta, mi è difficile applicare un giudizio «morale» in un universo e in un
tempo nel quale il monopolio statale della violenza è stato esercitato con tanta
ottusa brutalità.
E con tale sfoggio di buone coscienze. In una temperie culturale per cui
sarebbe violenza colpire direttamente e fisicamente qualcuno, mentre non lo
sarebbe far crepare di fame e di sete decine di milioni di persone, stroncare
anonimamente la vita di milioni di altre - come sono ladri due terzi di coloro
che riempiono le galere e non chi ha sottratto le smisurate somme nella
speculazione di questi mesi. Non giustifico né l’uccidere né il rubare, quale
che ne sia il movente, intendo mantenere un criterio per cui sia possibile
esaminare gli anni ’70 senza prima farsi frugare nell’anima, come all’aeroporto
nella giacca, per garantire che non sei una incline alle armi. Non mi pare meno
grave che le Brigate Rosse siano partite dall’idea che uno stato moderno possa
essere colpito colpendo un suo esponente, come se fosse un ex impero e non
tessuto fittissimo di rapporti e interessi che si tengono. È questo che ha reso
senza senso quelle morti, date e ricevute. Quindi crudeli, una colpa. Ma non
sordida, politica. E non per questo meno gravida di conseguenza.
Non però quelle che si dicono. Se Moro non fosse stato sequestrato e ucciso,
non avrebbe fatto il governo con il Pci, e Berlinguer sarebbe andato incontro
allo stesso scacco. Molto sarebbe cambiato, ma non la forma di stato e di
governo. Le istituzioni non furono mai in pericolo per causa dei 120 regolari
che le Br ebbero al loro punto massimo. La degenerazione covava ed è avvenuta su
altro. Anche questo sarebbe da studiare e discutere. Dovremmo permetterci di
farlo.
di Rossana Rossanda (Bellaciao.org, mercoledì 24 Dicembre 2008)
|